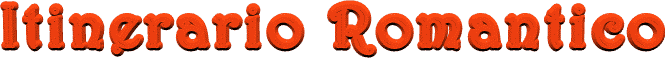
Quest’ itinerario
romantico
ci porta
a visitare
i tesori
dell’antica
Mazzè
Infatti
ci muoveremo
Per comprendere pienamente quanto ci accingiamo a visitare,
segnaliamo alcune note di storia mazzediese.
Nella prima metà del secolo scorso,
a
Mazzè
si produssero
due avvenimenti
di notevole importanza
per il suo futuro assetto urbanistico.
In primo luogo,
dopo la morte
avvenuta nel 1840
dell’ultimo
Conte Valperga-Mazzè
privo di eredi diretti,
Il
abbisognava di notevoli manutenzioni
che il vecchio
Conte
non era stato in grado di fare eseguire.
Il ricetto fortificato
che lo contornava
non era in condizioni migliori,
in quanto la popolazione
bramava
trasferirsi
in pianura
ai piedi del colle.
Il piano
era ormai sicuro dai nemici
e dotato,
con la costruzione della
di un comodo corso d’acqua
buono per tutte le esigenze.
Questi fatti
produssero
conseguenze importanti.
Il castello
acquistato dalla famiglia
assunse a nuova vita
ed un suo rampollo,
sposando
una nobile
russa
proprietaria in patria
di ingentissime ricchezze,
ebbe la possibilità
di restaurare
i castelli
donando al complesso
la struttura
tardo-neo-gotica
attuale.
L’Amministrazione comunale
del tempo,
a nobili di gran nome,
i quali,
come di moda a
Parigi ed a Londra,
desideravano passare l’estate
in campagna
lontani dalle arsure di
Torino.
Si costituirono quindi
sul colle
alcune grandi proprietà,
nate dall’accorpamento e dalla demolizione delle
ormai ritenute inutili
dopo il
diremo in dettaglio in seguito;
della
e della marchesa
invece parleremo immediatamente,
vista la notorietà dei personaggi
implicati in questa
romantica vicenda.
La marchesina
ebbe la ventura
di far innamorare di se
il suo maestro
nientedimeno che
l’autore della monumentale
allora esule in
Piemonte.
L’amore,
puramente epistolare
dell’illustre letterato
per la sua allieva durò,
come d’uso nell’epoca,
tutta la vita
ed è testimoniato
da una copiosa
serie di lettere
indirizzate dal
De Sanctis
alla bella
Virginia
sposata nel frattempo al
Conte Enrico Ricardi di Lantosca
ufficiale dell’esercito Sardo.
In ogni caso la marchesa
Basco
conservò gelosamente queste lettere
tanto che nel
1914
(allievo del De Sanctis)
desiderando stampare
una pubblicazione sul
De Sanctis
intitolata appunto
" Lettere a Virginia "
venne a
Mazze’
e la marchesa,
ormai molto anziana,
gliele consegnò
perché potesse copiarle
e pubblicarle,
cosa che puntualmente
il
Croce
fece qualche anno dopo.
Sull’onda di questo
romantico amore,
che ci introduce nella giusta atmosfera,
iniziamo la visita
partendo dal
Il complesso monumentale
è stata la dimora dei
Conti Valperga-Mazzè
per circa 800 anni
dai primi
dell’XI sec.
sino al
1840.
La casata ebbe momenti di splendore sino al
XV sec.
degnamente rappresentati da
il quale,
per i suoi meriti,
divenne generale
e ciambellano
La singolare vita di
Giorgio di Valperga
Conte di Mazzè
snodatasi nei decenni posti a cavallo fra
il XIV ed il XV secolo,
è illustrata in una pubblicazione edita qualche anni fa dalla
Get di Chivasso
scritta dall’autore di questo testo.
Dopo il
XV sec.
il feudo
seguì le sorti dei
Savoia
ma sempre in posizioni di secondo piano
il momento magico dei
Conti del Canavese
era ormai passato.
Il castello
seguendo questa parabola
nel
XVI sec.
ebbe l’occasione di ospitare il
re di Francia Francesco I
ma ormai era ridotto
ad un maniero di campagna,
senza più alcuna
utilità militare
se non quella
di mantenere
una piccola guarnigione sabauda.
Questo stato di cose
durò sino all’acquisto del complesso
da parte dei
Brunetta d’Usseaux
antica famiglia di origine francese
al servizio dei
Savoia
i quali lo riportarono a nuovo splendore.
Il restauro si concluse con
il quale,
finanziando grandi lavori,
sia nella parte più antica posta verso la
Dora
edificata nel
1317
sulle rovine di un
castello preesistente,
sia nella
casaforte posta a sera,
col tempo divenuta
pertinenza agricola,
diede al complesso l’aspetto attuale.
Sotto la direzione
dell’arch. Giuseppe Velati-Bellini
presero forma
due manieri
di fattura squisitamente
neo-gotica
con un cortile ed un parco,
esteso sino al fiume,
degni di ammirazione.
Da vedere
gli affreschi
di stile quattrocentesco
di
Romolo Bernardi
dipinti nel portale d’onore,
nelle pareti dello scalone
e nella sala del trono.
Notevoli gli intarsi
eseguiti
sempre nella sala del trono,
da
Carlo Arboletti
ed il camino in pietra
costruito
dai fratelli Catella.
Degni di nota infine
i soffitti della sala da musica
e
nel salone gotico
eseguiti dal pittore
Giovanni Beroggio.
Dopo la tragica morte di
primo
e finora
unico italiano
segretario del
Comitato Olimpico Internazionale
i due castelli
andarono preda
di ogni sorta di ingiurie
e l’archivio del C.I.O.
andò disperso.
Di quegli anni
sono da ricordare le visite del
Principe di Piemonte Umberto di Savoia
e di
durante l’esecuzione di manovre militari.
Corrado Salino,
proprietario del Castello
prima degli attuali Castellani russi,
con indubbio gravame economico,
ha salvato i due manieri dalla rovina,
ripristinando i muri di sostegno
verso il fiume
ed eseguendo
altre opere di restauro
divenute ormai improcastinabili.
Negli ultimi tempi
è stato inserito nei sotterranei un
museo delle torture.
Il complesso monumentale,
dichiarato
Monumento Nazionale
e in certe date
Usciti dalle mura del castello
e percorsa la stradina in discesa
arriviamo alla piazza
sulla quale prospetta la
titolata ai
Santi Gervasio e Protasio
vecchia chiesa gentilizia
dei Conti di Mazzè
divenuta
unica parrocchia
del feudo
tra il
XIV ed il XV sec.
dopo la soppressione
delle antiche parrocchie
titolate a
Santa Maria
ai
e forse a
San Pietro.
Il primo nucleo
della chiesa parrocchiale
è probabilmente
coevo
al castello
ed in origine
era limitato
alla attuale
navata centrale
con il pavimento
posto a livello
dell' attuale presbiterio.
Successivamente
l’edificio
subì una serie innumerevole
di ampliamenti
sino ad assumere
l’attuale struttura basilicale
a tre navate.
Anticamente
era posto
a sinistra dell’entrata,
nel sito
dove adesso
sorge
il fonte battesimale,
mentre quello attuale
realizzato
sopraelevando
l’antica torre del ricetto
è stato realizzato
nella prima metà del
XVIII sec.
in forme barocche.
Nel corso del
XIX secolo
sono stati realizzati
i grandi lavori
che hanno donato alla chiesa
l’attuale aspetto.
Nel 1879
allo scopo
di aumentare
la cubatura interna,
è stato abbassato
di oltre un metro
il piano pavimento,
salvo
la zona
dell’altare maggiore
e dell’abside,
mentre qualche anno prima,
nel 1875,
era stata realizzata
la facciata
decorata da
Agostino Visetti,
al quale si deve inoltre
con i
Santi Patroni Gervasio e Protasio
posto sopra
l’altare maggiore.
All’interno dell’edificio
si possono ammirare
buone opere pittoriche
di scuola piemontese
del XVIII sec.
una bella balaustra in marmo intarsiato
contornante l’altare maggiore
e l’interessante organo
del XIX sec.
posto sopra
la bussola d’ingresso
ed ancora perfettamente funzionante.
Notevoli
contornata da angioletti,
opera probabilmente del
XVIII secolo
forse ricavata
da un unico ceppo di castagno
e restaurata
nei primi anni del secolo scorso,
situata
a destra dell’entrata
e la
lapide romana,
di epoca imperiale,
rinvenuta nella chiesa dei
Santi Lorenzo e Giobbe
nel 1993
Meritano una visita
la tomba del
Conte Francesco Valperga-Mazzè,
ultimo della sua dinastia,
posta
al fondo
della navata destra
e la sagrestia,
nella quale sono conservati
arredi e paramenti sacri
di notevole fattura.
Uscendo dalla chiesa
dalla porticina posta nella navata sinistra,
ai piedi della scalinata dell’altare maggiore,
accediamo al rilevato contornante l’edificio,
anticamente adibito
a cimitero,
ospitante anche
la torre del ricetto
ora adibita a
Evoca un'atmosfera
particolarmente romantica
invece,
la
che dal sacrato della Chiesa,
conduce in
Via delle Scuole.
Questo passaggio suggestivo,
risulta coperto e due archi in
e in
del condotto,
la Chiesa della Confraternita di Santa Marta
(a suo tempo sconsacrata ed ora sede del ristorante "Santa Marta")
con la Chiesa Parrocchiale.
Le due piccole rampe
di scale si incontrano su di un
acciottolato e semibuio.
Uscendo dalla torre campanaria
e scendendo
per il passaggio
coperto alla via sottostante
si arriva al
situato a sinistra all’angolo con
via Municipio.
Questo
costruito
nel 1759
dall’arch. Giuseppe Pozzo
presenta un elegante porticato
prospettante sulla piazza della chiesa,
ma è purtroppo in uno stato di vergognoso degrado
da quando,
la sede comunale è stata trasferita in pianura.
L’antico ricetto,
con il suo intrico di stradine,
delimitato un tempo dalla
porta Frera
(ferrata)
posta sulla
Via Municipio
a lato della contigua
chiesa di San Vito
ora demolita
merita una passeggiata.
Notevole la
con il
collegante
con la proprietà frontaliera.
ora di proprietà Occhetti,
edificato in sobrio
stile agreste piemontese
del XIX secolo
come il parco che la contorna
e la pertinenza agricola
prospettante verso la
sono sorti
sullo spazio ricavato
dalla demolizione
dell’antico borgo di
Santa Maria
certamente d’origine medioevale,
ma posto fuori del
ricetto fortificato.
è ben conservato.
L’area,
essendo di proprietà privata,
è visitabile solo in occasione di particolari circostanze.
Identica constatazione
vale purtroppo
per le ville
e
situate,
come i loro parchi,
a sud della piazza della chiesa.
Entrambi le proprietà
sono sorte
dalla demolizione
della parte principale
del ricetto,
anticamente sito a mezzogiorno
del castello.
Sia la villa
appartenente a suo tempo
alla principessa d’Ischitella,
e sia la
attualmente di proprietà della
ed alla famiglia Sardi,
sono costruite
sulla falsariga
dei palazzi nobiliari di campagna
inglesi e francesi
del XVIII e XIX sec.
e presentano punti d’interesse notevoli,
sia sotto l’aspetto architettonico,
sia nella varietà
degli impiantati arborei
eseguiti dai proprietari.
Al visitatore,
consigliamo ancora di ammirare
sul vallone della Dora
godibile dal
recentemente riattato
e di fare ritorno al punto di partenza.
Livio Barengo
Mazzè Luglio 2004

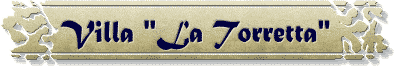

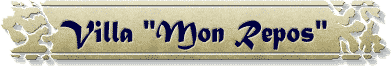
.......dicono di noi....

