Negli anni ottanta
nasce ed è attivo a
Mazzè
l'A.P.P.
un gruppo di fotoamatori
che coniuga il piacere di scattare immagini fotografiche
con
l' interesse per il territorio in cui vive.
Delle tante iniziative promosse dall'
A.P.P.
indubbiamente rimane vivo il ricordo
della
mostra fotografica
sulla fitta rete di canali
irrigui
che hanno origine o scorrono nel territorio mazzediese.
La mostra riscuote
un indiscutibile interesse,
ed è per questo che a distanza di molti anni
ne riproponiamo alcune foto
e il testo.
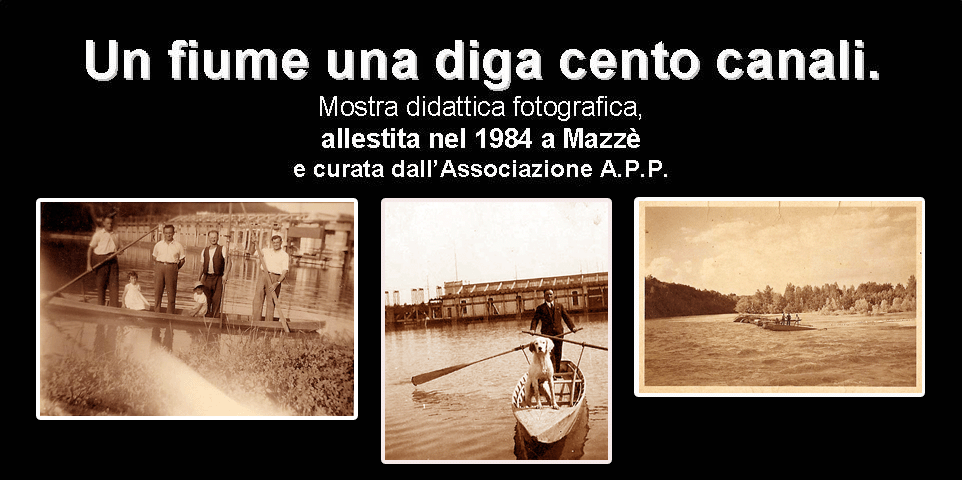
Immagini e storia di una terra bagnata dalla Dora Baltea
Se si percorrono
le strade sterrate di campagna
o ci si avventura lungo i sentieri
polverosi dei boschi del mazzediese,
si ha l'impressione di essere imbrigliati in una
sorta di grande ragnatela
la cui tela e la cui trama
sono sapientemente costituite
dalle numerose rogge,
dai numerosi fossi, canali
che ricevono acqua dalla Dora,
e la distribuiscono ai campi.
Questa preziosa opera di canalizzazione
iniziata secoli or sono
ha reso possibile
una coltura agricola
non più dipendente esclusivamente
dall'andamento
più o meno regolare delle piogge.


































CENNI SULL'AGRICOLTURA
IN PIEMONTE DAL PERIODO PREROMANO FINO AL SECOLO XI
L'agricoltura preromana in Piemonte, non godeva di molta prosperità.
Per tanti aspetti assomigliava a quella praticata dai popoli nordici. Era purtroppo
molto arretrata coi tempi, ciò era in parte dovuto al fatto che nella
nostra regione non giunse l'influenza della civiltà etrusca, che invece
nei territori sottoposti a propria colonizzazione lasciò importanti esempi
di ingegneria idraulica con opere di canalizzazione e di prosciugamento di zone
paludose. Pure i romani praticarono però molte bonifiche e ci insegnarono
a sanare i terreni paludosi per scopi agricoli ed igienici, ed è così
soltanto dall'epoca romana che noi abbiamo sicure testimonianze delle condizioni
agricole del Piemonte. In tutta la regione alpina esisteva una economia di monte
a carattere forestale e minerario, ed una di valle a carattere agricolo. Esistevano
pure delle contese interne alla regione, tra i Salassi, popolo della Valle d'Aosta,
ed i Libici, abitanti dell'agro Vercellese, originata dal fatto che i primi,
deviando l'acqua della Dora per le loro ricerche minerarie privavano i secondi
della possibilità di poter irrigare i loro terreni. Ciò dimostra
l'antica esistenza di una rete irrigua e di una notevole estensione di prati
e quindi una ricchezza di bestiame. Certo è quindi che, all'epoca della
dominazione romana in Piemonte iniziarono i primi lavori di sboscamento e le
prime bonifiche e canalizzazioni. Sappiamo che i romani concedevano ai militari,
a titolo di gratificazione, terre incolte con l'obbligo di bonificarle, ma mentre
nell'Italia centrale e meridionale il governo di Roma eseguì una sistematica
espropriazione dei popoli vinti, questi invece nell'Italia settentrionale, conservarono
le proprie sedi e le terre che coltivavano, per cui, quando nelle altre regioni
alla piccola proprietà si sostituì il latifondo, nell'antica Gallia
Cisalpina, invece, la piccola proprietà rimase il tipo predominante di
conduzione e di possesso. I Romani non mancarono di introdurre anche in Piemonte
nuove colture e nuovi metodi di coltivazione, le bonifiche terriere si svolsero
principalmente lungo le strade imperiali ove esistevano città e centri
rifornimento di viveri, di ricambio animali e di concentramento vettovaglie.
Occorre tener presente le condizioni geologiche dei nostri terreni e considerarne
la produttività in rapporto ai loro elementi costitutivi, alla loro acidità
o alcalinità, al loro maggiore o minore potere assorbente e in rapporto
all'impossibilità di irrigazione di molti di essi. Infatti la natura
ciottolosa-ghiaiosa dei terreni e la loro configurazione planimetrica ed altimetrica,
ha causato, già in antico, la troppo ineguale ripartizione delle falde
acquifere, per modo che, mentre alcuni terreni potevano essere irrigati, altri
erano assolutamente privi d'acqua, ed al contrario molti erano impaludati, così
come lo rileviamo dalle carte medioevali. Ma ancora si deve considerare l'estensione
dei boschi e le conoscenze tecniche agricole del tempo in fatto di miglioramento
del terreno e quelle inerenti le diverse colture, nonché tener presente
delle continue guerre e delle condizioni demografiche, sociali e sanitarie generali,
favorevoli allo sviluppo di pestilenze che decimavano le popolazioni agricole.
Le condizioni agricole del Piemonte non migliorarono nei primi secoli successivi,
poiché ancora verso il "mille" abbiamo una grande distesa di
boschi , di paludi, di gerbidi di prati e una ristretta porzione coltivabile
riservata ad un limitato sviluppo viticolo, certo non superiore a quello descritto
da Plinio molti secoli prima. Tra i cereali, oltre al poco frumento, primeggiava
la segale, che però mal coltivata, così da dare una farina molto
scura, che costituiva un pessimo cibo, ingratissimo al ventre, di cui non si
riusciva a mitigare l'amarezza neanche mescolandone la farina con altri cereali.
Ciò ci fa comprendere quanto fossero diffuse nei cereali le malattie
crittogamiche, ed in particolare, la segala cornuta, che fu anche in parte causa
dell'antica denatalità regionale, per il potere abortivo dei suoi sclerozi
nero- violacei, che venivano macinati con i granelli del cereale, e causa anche
di quell'ergonismo cronico di cui era rimasto esempio in alcune nostre vallate
alpine fino al primo decennio del millenovecento. I documenti della fine del
X e del principio dell'XI secolo ci rappresentano il Piemonte coperto in diversi
punti da vaste estensioni boschive. Nel Biellese, tutta la regione morenica
della Serra e tutta la zona nord-occidentale compresa tra i fiumi Dora Baltea,
Elvo e Cervo, costituiva una grande foresta. Così pure tutto il basso
Canavese era quasi interamente coperto da boschi.
LA LEGISLAZIONE
MEDIOEVALE DELLE ACQUE
Quantunque la legislazione romana regolasse l'uso privato delle acque, con leggi
delle quali Platone celebra il valore, essa considerava le acque dei fiumi e
dei torrenti come beni comuni. Solo da Giustiniano (462-565) venne definito
il diritto di derivazione e fu avocato allo stato il diritto di concessione
d'acqua. Fu poi l'imperatore Federico I (Il Barbarossa) che nella famosa Dieta
di Roncaglia del novembre 1158 modificò sostanzialmente le leggi romane,
alle quali, si andavano uniformando i comuni che man mano si andavano emancipando,
rivendicando all'impero, con la "Costitutio de regalibus" anche la
proprietà delle acque dei fiumi, che fu considerata regale e spettante
all'imperatore. Questi poteva poi alienare il suo diritto di proprietà
sui corsi d'acqua, sia a titolo oneroso che gratuito, in compenso di servigi,
e concedendo il dominio utile di essi a perpetuità. Dalle concessioni
sovrane, i signori si valevano con sub-concessioni agli agricoltori, dai quali
esigevano compensi in denaro e in natura. Quasi sempre le costruzioni di canali
venivano eseguite dai feudatari, che esercitavano poi su di essi il "Jus
molinendi" che dava loro degli introiti molto importanti, perché
obbligavano i sudditi a macinare i propri prodotti nei loro mulini. Il regime
feudale delle acque ebbe a favorire i furti. Le derivazioni abusive con le quali
si guastavano gli alvei dei canali e le opere di presa, si ripercuotevano sulla
regolarità dell'irrigazione. Inoltre l'esercizio della "Jus molinendi",
per il quale era data ogni precedenza, impediva l'irrigazione laterale dei fondi
a monte degli edifici idraulici. La legislazione statutaria medioevale, nonostante
tutto, è la prima a stabilire la servitù prediale di acquedotto
e ne regola l'applicazione con sagge disposizioni. Ogni cittadino poteva condurre
le acque attraverso i terreni incolti spettanti al comune, onde irrigare i suoi
prati, purchè ciò fosse fatto senza arrecare danno ad alcun privato.
In Piemonte, occorre giungere sino agli inizi del secolo XV per trovare la prima
grande opera idraulica. La costruzione del naviglio di Ivrea ebbe inizio nel
1448, regnante Amedeo VIII. Ma ben presto i lavori dovettero essere abbandonati,
perché, quando Amedeo IX salì al trono (1465) l'impresa era già
caduta nell'oblio. L'abbandono dell'opera va forse anche attribuito al particolare
carattere del duca, che poco si curava del governo dello stato, sia per la sua
profonda dedizione alle pratiche religiose e sia perché affetto dal mal-caduco.
Nelle cure del governo, gli diede aiuto la moglie Jolanda, figlia di Carlo VII
di Francia (1434-1478), alla quale finì per cedere la reggenza del trono
dell'aprile del 1472, essendo il figlio Filiberto ancora in minore età.
Pertanto Jolanda, probabilmente sollecitata dai piemontesi, riconobbe l'utilità
di un tale ardito progetto e decise di condurlo a termine. Si convenne su parere
di giureconsulti, che il duca aveva il diritto di dedurre l'acqua, che i cittadini
dovevano contribuire alle spese, esclusi gli ecclesiastici (i preti), e che
ai proprietari dei fondi si poteva fare obbligo di tagliare gli alberi troppo
vicini e di purgare l'alveo. Dopo alcune sospensioni dei lavori, l'opera iniziata
a due riprese (1448/1468), risulta compiuta nell'ottobre del 1474 e già
qualche anno più tardi doveva essere in piena funzione.
Il naviglio di Ivrea: scopo principale dell'opera
Alcuni storici danno più credito all'ipotesi che la costruzione del naviglio
si rese necessaria per unire Ivrea a Vercelli tramite una comoda via d'acqua
utilizzabile in ogni stagione dell'anno con piccola navigazione e per favorire
la costruzione di piccoli molini marchionali , subordinando l'esigenza di irrigazione
della campagna dominata dal canale, in quanto a quei tempi mancavano nel vercellese
le premesse per fare dell'agricoltura, un'attività veramente redditizia
e tanto meno esisteva una sistemazione idraulica del terreno.
Abbandono dell'utilizzo del naviglio di Ivrea ad un secolo
dall'apertura
Le devastazioni, le carestie e le pestilenze che seguirono la dominazione Franco-Spagnola
dal 1538 al 1560 e poi quella Spagnola dal 1633 al 1659, furono senz'altro motivo
di rallentamento alla libera iniziativa dell'epoca, per cui ne risentì
sensibilmente anche l'utilizzazione e la valorizzazione del naviglio stesso.
Nonostante tutto, fin dal 1608, il duca Carlo Emanuele I di Savoia propose di
riattivare il naviglio di Ivrea che le sabbie convogliate dalla Dora Baltea
avevano ostruito. Fu dato incarico di studiare anche un progetto alternativo,
presentato sempre nel 1608 (tra l'altro mai realizzato) in cui si prevedeva
la derivazione di un canale alla stessa quota del primo, che avrebbe raggiunto
il lago di Viverone ove le acque riversatevi sarebbero decantate facendo cadere
le sabbie sul fondo ed un altro canale le avrebbe fatte defluire sino ai territori
di Cavaglià, Massazza, Buronzo, Castelletto, Rovasenda, Ghislarengo,
terminando nel Sesia. La riattivazione del naviglio fu sospesa comunque poco
dopo l'inizio dei lavori (1608) per le vicende politiche del tempo. I lavori
ripresi nel 1650, furono finalmente portati a termine dal marchese Carlo Giacinto
di Pianezza, che assunse a proprie spese l'incarico di perfezionare l'antico
tracciato del canale, in modo da renderlo navigabile. In cambio pretese metà
delle rendite del naviglio medesimo ed il rimborso di metà delle spese
sostenute. Successivamente, con patenti del 11/3/1670, si stabilì che
il marchese di Pianezza avesse in feudo il naviglio, di cui ebbe in effetti
investitura il 3/4/1674. Alla Rocca di Villareggia, su di un pilastro, si trova
ancora incassata una lapide
che ricorda l'avvenimento.
Leonardo da Vinci ed il naviglio di Ivrea
La progettazione della derivazione del naviglio di Ivrea la si vuole attribuire
a Leonardo da Vinci. Lo storico Francesco Carandini nella sua "Vecchia
Ivrea" riporta infatti che nel "Codice Atlantico" di Leonardo,
riprodotto e pubblicato dall'"Accademia dei Lincei" (Biblioteca Ambrosiana
di Milano) con la trascrizione critica del testo da parte del professor Giovanni
Piumato, al foglio (211 V/2) esiste un disegno di Leonardo rappresentante un'opera
di derivazione di acque con un ponte canale a tre archi, e le tre note seguenti,
scritte come egli usava alla rovescia, in modo che si possano leggere soltanto
con l'uso dello specchio. "NA.VI.LIO DIN.VREA. FACTO. DA FIUME. DELLA DOIRA.
MONTAGNI. D'INVREA. NELLA. SUA PARTE. SILUAGIA. PRODUCE. DI. VERSO TRAMONTANA
IL GRAN PESO DELLA BARCA CHE PASSA PER IL FIUME SOSTENUTO DALL'ARCHO DEL PONTE
NON CRESCIE PESO AESSO PONTE PERCHE' LA BARCHA PESA DIPUTO QUATE E IL PESO DELL'ACQUA
CHETTAL BARCHA CHACCIA DEL SUO SITO" La disserzione tra i due storici,
il Carandini ed il Solari, rispetto alla interpretazione esatta della frase
"Facto da fiume della Doira" sta' nell'interpretazione che il primo
vede progetto e relativo disegno e lo interpreta come naviglio derivato dal
fiume Dora, mentre il secondo lo traduce come: progetto riportato sul "Codice
Atlantico" ed eseguito dall'artista prevedendone l'attuazione sulle rive
della Dora, il che potrebbe dar credito all'ipotesi sostenute da alcuni anziani
abitanti della Rocca di Villareggia che in base a testimonianze tramandate di
generazione in generazione, attribuiscono a Leonardo la realizzazione dello
scaricatore della Maddalena, effettivamente molto prossimo al corso della Dora,
in cui riversa le proprie acque dopo un salto di alcuni metri. L'intervento
di Leonardo quindi sarebbe stato necessario e risolutivo, stando a tali
affermazioni, per dissabbiare il naviglio e permettere la defluenza idrica.
Altro progettista della derivazione del naviglio fu senza dubbio Carlo dei conti
di Castellamonte. Troviamo tale testimonianza nell'opera di Antonio Benvenuti,
storico di Ivrea, il quale scrisse che nel 1563, rottisi per inondazione i margini
del canale, questi si rese inservibile e quasi privo d'acqua, ciò sino
al 1616, anno in cui, per ordine di Carlo Emanuele I, su disegno del signor
Carlo di Castellamonte "si rifece come al presente" (ciò fu
scritto alla fine del 1700). Il naviglio non ricominciò a funzionare
se non molto tempo più tardi.
Il naviglio deriva le sue acque dalla Dora Baltea, presso Ivrea, a 237 m. sul
livello del mare, serpeggiando con delle pendenze che vanno dallo 0,60 ad 1,50
m./km. lungo l'anfiteatro morenico con direzione nord-sud. Giunge
al passo di Mazzè ad un livello di circa 20 m. superiore al fiume
che gli ha dato origine. Di qui continuando a svolgersi lungo la declinante
parete della collina morenica, sbocca a livello della pianura presso il caseggiato
della Rocca a m. 224 sul livello del mare, ove cambia bruscamente direzione
volgendosi verso nord-est sino a raggiungere Santhià. Dopo questa località,
assunta la nuova direzione di sud-est, prosegue per Vercelli . La sua lunghezza totale è di km.73,920.
Il naviglio di Ivrea via del sale
Nel corso della sua travagliata storia il naviglio, più volte sacrificato
alle bizze dei regnanti ed alle alluvioni che lo resero inservibile, non tralasciò
comunque di adempiere al suo compito primario ; con barche o con carri il naviglio
servì sempre come mezzo di comunicazione, e dal "Canalis" sappiamo
che per causa del cattivo stato delle strade esso fu, un tempo per Ivrea, "la
via del sale". Mentre dal "Tesauro", in relazione
all' assedio di Ivrea (aprile 1641) da parte delle truppe francesi del marchese d'Harcourt , in guerra contro il ducato di Savoia , sappiamo che i francesi alloggiarono nel canale arenato
e disattivato.
Il naviglio di Ivrea : conclusione
E' evidente comunque che questa via d'acqua, concepita forse inizialmente per
soddisfare esigenze di comunicazione, ha senza dubbio costituito più
tardi l'inizio di una razionale irrigazione nel Piemonte, alla quale l'odierna
agricoltura deve in gran parte la sua realizzazione. Ma vi è di più,
l'irrigazione nel vercellese è stata, grazie al naviglio di Ivrea, il
mezzo attraverso cui si sono bonificati molte centinaia di ettari di territorio,
ed ancora oggi troviamo conferma di questa tesi nella bonifica della Baraggia
Vercellese.
II CANALE DEL ROTTO
Di data antecedente la costruzione del naviglio di Ivrea risulta la costruzione
del canale del Rotto, voluta da Giovanni del Monferrato verso la fine del 1300
e l'inizio del 1400. La tradizione fa risalire ai monaci cistercensi di Lucedio
il merito di aver introdotto e diffuso la coltura del riso nella loro abbazia
e in tutto il Vercellese. È attribuibile anche al loro intervento la
costruzione di uno dei canali fondamentali per l'agricoltura vercellese, il
canale del Rotto. Infatti una violenta piena del fiume Dora Baltea, aperse un
varco nel territorio di Saluggia, definito Rotto. I Marchesi
del Monferrato ne approfittarono per costruire il noto canale; in quegli
anni l'abbazia di Lucedio era sotto il patronato dei Marchesi
del Monferrato e i monaci intervennero nella costruzione, garantendosi i
due terzi della proprietà e godendo in modo privilegiato dell'acqua per
le loro risaie. La presa originaria del canale nel territorio di Saluggia, fu
spostata, in seguito a breve distanza dalla derivazione del Canale Depretis.
Il Rotto viene attualmente alimentato da scaricatori
del canale Depretis in prossimità dell'Elevatore
idraulico di Cigliano.
LA ROGGIA DEI BOSCHETTI
Di epoca antecedente la costruzione del naviglio di Ivrea si presume sia anche
la Roggia dei Boschetti. Ciò si deduce dal fatto che, derivando la roggia
le proprie acque dalla Dora in località "La Benna", con l'avvenuta
costruzione del naviglio di Ivrea, quando il fiume diminuiva sensibilmente la
propria portata, le acque venivano esclusivamente incanalate nel naviglio, lasciando
a valle il letto del fiume e quindi anche la Roggia dei Boschetti asciutta .
Gli agricoltori di Mazzè, le cui campagne venivano irrigate in gran parte
dalla Roggia, rivendicarono un antico diritto ad usufruire sempre e comunque
di una certa quantità d'acqua indispensabile alle coltivazioni. Furono
quindi disposte due bocche attigue alla diga di derivazione del naviglio, sulla
Dora, ad Ivrea, che assolvevano appunto al compito di assicurare una misura
(modulo) anche in caso di scarsità d'acqua.
LA ROGGIA NATTA
Per tornare alla storia documentata, si sa per certo che nel 1723 venne costruita
la Roggia Natta in territorio di Rondissone e che, secondo la domanda di riconoscimento,
deriva una portata massima di 4500 litri al secondo ed irriga circa 1814 ha
di terreno, dei quali , 1600, in territorio di Verolengo, ed il rimanente nei
territori di Rondissone, Saluggia, Mazzè.
LA LEGISLAZIONE
SABAUDA SULLE ACQUE DI USO AGRICOLO
Nel 1567 il duca Emanuele Filiberto, allo scopo di unificare l'amministrazione
delle acque, istituiva un magistrato speciale per le acque. Carlo Emanuele I,
con un decreto (15/1/1584), crea la prima legge sulla espropriazione di terreni
per pubblica utilità, nel caso in cui si debbano attraversare con opere
di canalizzazione. Con decreto del 3 settembre 1619 Carlo Emanuele ordina il
"consegnamento" di tutti i fiumi, torrenti, stagni, laghi, bialere,
onde stabilire quali fossero le acque demaniali e quali quelle private e perciò
decretare le disposizioni da osservare sulle derivazioni d'acqua, introducendo
nella prima metà del secolo (1600), apposite leggi che regolavano le
forme di adacquamento (domande di adacquamento). Pure in tale secolo, furono
emessi numerosi decreti per impedire le inondazioni e le corrosioni dei fiumi.
Furono istituiti dei roggiari preposti alla vigilanza dei canali e delle loro
opere di presa, i quali dovevano anche occuparsi della giusta distribuzione
delle ruote.
IL CANALE DI
CALUSO E LA ROGGIA DI MAZZE'
Nei primi anni del 1500, il Canavese
divenne provincia francese, e Mazzè veniva da questi occupata nel 1536, per
mezzo del loro capitano di ventura Torregiano. La trattennero per poco, perché
vi subentrarono gli Spagnoli comandati da Cesare Maggi di Napoli che accorso
al contrattacco, scacciava da Mazzè, Emilio Greco, che Torregiano vi aveva posto
come governatore. In quell’occasione fu concesso ai Francesi, che si erano assestati
sulla linea della Dora Baltea, di uscire da Mazzè con tutte le loro armi ed
il loro equipaggiamento.
Gli anni che seguirono, non furono
migliori, perché gli avvenimenti succeduti non mutarono affatto il volto della
contesa franco-spagnola. L’ostilità fra i due belligeranti fu una profonda piaga
per la nostra popolazione e per i nostri Comuni, finchè nel
nel 1554 i Francesi , dopo un primo tentativo fallito, si portarono all’assedio
di Ivrea.
Si distinse allora un brillante ufficiale
francese, Carlo Cossé conte di Brissac. Favorito dai Piemontesi, che erano stanchi
del giogo e della prepotenza degli Spagnoli, concentrò su queste campagne un
esercito forte di 18.000 fanti e 12.000 cavalli, e nel mese di dicembre di quell’anno,
mosse all’assedio della città eporediese. Gli Spagnoli, inferiori per numero
e per armamento, furono costretti a cedere e ad abbandonare
la città alla volta di Vercelli.
Intanto la Francia rimaneva padrona
del Piemonte e si fortificava nelle città più importanti.
Il generale Brissac, divenuto poi
maresciallo per i brillanti servizi resi al suo paese, rivolse le sue mire su
queste terre e, dopo un richiamo in Francia, ritornò, scegliendo come sua dimora
e residenza, il feudo di Caluso, di cui si era invaghito.
Fu colpito dalle tristi condizioni
delle campagne e dalla povertà dei suoi abitanti. Studiò il modo di trarre Caluso
e le terre circostanti dalle ristrettezze
e dalla miseria in cui languivano, e fece elaborare un piano per irrigare
l’arida campagna.
Ottenuto l’autorizzazione del suo
sovrano Enrico II, il quale amava definire il Canavese
“Il bel paese di conquista”, acquistò subito i terreni necessari e fece
scavare l’alveo per immettervi le acque che avrebbe poi fatto derivare dal fiume
Orco, nei pressi di Spineto, vicino a Castellamonte.
Caluso vide il canale in funzione
verso la fine dell’anno 1559 e ne trasse subito un enorme beneficio.
Quando le truppe francesi sgombrarono
definitivamente il Piemonte, il Brissac cedette le prerogative sul canale di
Caluso a certa Anna di Alençon, marchesa di Monferrato.
LA ROGGIA DI
MAZZE'
Oltre due secoli più tardi, nel 1765,
a questa “bealera” venne collegata la roggia comunale di Mazzè, dopo aver ottenuto
la concessione di una ruota d’acqua derivata dal canale, per l’irrigazione delle
sue terre.
L’11-12-1765,
infatti, la Comunità di Mazzè ebbe la facoltà di estrarre dalla “ bealera di
Caluso” una ruota d’acqua (12 once)
per “...condurla nel territorio della Comunità e destinarla nel modo migliore
che fosse stato stimato a vantaggio del pubblico”.
Le spese
incontrate per l’acquisto del terreno e per l’escavazione del canale di irrigazione,
e la tassa annua fissata dalle R.Patenti, rappresentarono allora un pesante
onere, sia per la popolazione che per il Comune, che accettò e assunse tutti
gli impegni.
Le dichiarazioni
e le condizioni nel documento originale , rappresentano ancora oggi, le clausole
comprovanti un diritto che Mazzè gode da circa duecento anni, e che regolano
tutt’ora questo corso d’acqua comunemente denominato “Roggia di Mazzè” . Esse
dettano testualmente:
1° “che la
derivazione d’acqua suddetta si eseguisca bensì in quel territorio e sito che
detta Comunità crederà più conveniente per condurla alla sua destinazione, ma
però il bocchetto o sia regolatore
per l’estrazione dell’acqua dalla bealera, debba essere costrutto e mantenersi
dalla Comunità nella forma che verrà giudicata prescritta dal Perito deputato
per parte del Regio Patrimonio”.
2° ”che le
spese della derivazione e formazione del bocchetto suddetto e così tutte le
altre che potranno esse necessarie per condurre l’acqua alla sua destinazione,
siano interamente a carico della Comunità.
3° “ che
la concessione dell’acqua suddetta si intenda continua, salvo in tempo della
curatura dei detta “bealera”, e in casi di indispensabili riparazioni d’essa
cagionate da qualche particolare incidente. E tale concessione mediante l’annua
somma di lire 2 mila da corrispondersi da detta Comunità alla Regia Finanza
in fine di ogni anno principiando dal prossimo anno 1766”.
Tratto
Dal libro "Mazzè memorie della mia terra "di Francesco Mondino.
Dall'ipotesi di un progetto grandioso, alla costruzione del
Canale Depretis
Il Conte di Tonengo, verso il 1780, chiamò dall' Olanda uno speciaslista
di progetti idraulici, il quale espose un grande progetto che poco si scostava
da quello del 1608 (spurgo nel lago di Viverone e riversamento delle acque nel
Sesia). Scopo di tale progetto era semplicemente quello di portare l'acqua della
Dora Baltea (abbondante nei mesi caldi per lo scioglimento delle nevi) a rimpinguare
il Sesia che diminuisce la propria portata nella stessa stagione. Tale progetto
non si concretizzò e anziché costruire un canale che potesse valicare
l'Elvo e il Cervo, si addivenne alla costruzione del Canale di Cigliano (ora
Depretis), che fluisce nell'Elvo, anziché partire da Ivrea, venne dedotto
molto più a valle, a Mazzè. Fu proprio a seguito di un regio biglietto
o decreto del 21/1/1783 che Vittorio Amedeo III ordinò la costruzione
del canale (della portata di 20mc/sec). Dopo quattro mesi il canale, con portata
ridotta a 18mc/sec era terminato. Fu attivato però soltanto nel 1785
e fu denominato Canale di Cigliano, nome che venne tramutato nel 1887 in Canale
Depretis. Nel 1858, grazie all'intuito del progetto, il canale fu ampliato ad
una portata di 45 mc/sec.
Quote
livello pompe-bacino presa d'acqua-bacino di scarico
Nel 1889 entrava in funzione l'importante
Elevatore idraulico di Cigliano, che permette di elevare l'acqua fino alla frazione
di Gerbido dando origine al Canale Consorziale di Cigliano. L'acqua discesa per mezzo di un primo condotto dal Naviglio dì Ivrea, al piano delle pompe, entra in queste e risale per il secondo condotto, il quale comunica con il primo per mezzo appunto delle pompe, sino alla stessa altezza da cui è scesa per la legge fisica dell'equilibrio dei liquidi in vasi comunicanti. Giunta a questa altezza, le pompe agiscono su di essa e con la pressione esercitata, la spingono forzatamente sino all'estremità superiore della condotta, dalla quale passa in apposito bacino detto di scarico. La differenza di livello tra: pelo estivo del Naviglio di Ivrea e il locale pompe, è pari a m.20,10. La differenza di livello tra il locale pompe e il pelo d'acqua del bacino di scarico, è di m.40,10. Quindi il dislivello tra il pelo estivo del Naviglio d'Ivrea e il pelo acqua del bacino di scarico, è pari a m.20. Sono solo quindi, questi 20 m. che necessitano di una spinta per giungere a destinazione. Questa spinta, viene fornita
dall'elevatore. L'acqua per forza motrice, necessaria a far funzionare le pompe, viene fornita dal Canale De Pretis.
Genialità per sollevare l'acqua
A valle della Presa del Canale Depretis si trovano l'edificio e le condotte di un importante Elevatore Idraulico (detto "di Cigliano"), che svolge un ruolo fondamentale nell'economia agraria della zona.
Nel 1878, per iniziativa di don Evasio Ferraris (già cappellano militare, che nel 1851 era stato nominato viceparroco di Moncrivello), si costituì il consorzio dei proprietari interessati alla costruzione di un impianto d'irrigazione che permettesse l'innalzamento, di almeno 20 metri, di una portata di circa 1000 litri d'acqua al secondo, prelevati dal Naviglio d'Ivrea, per irrigare aree non ancora servite dalla rete dei canali esistenti. Fra i vari progetti presentati fu scelto quello dell'ingegner Locarni di Vercelli, che prevedeva un sistema piuttosto complesso di prelievo e sollevamento delle acque, sfruttando i 3 canali Depretis, del Rotto e Naviglio d'Ivrea.
Il progetto che fu realizzato si basa su una stazione di pompaggio più bassa di circa 20 metri rispetto al Naviglio d'Ivrea: le acque qui convogliate da apposita condotta risalgono poi alla stessa quota di partenza per forza naturale (principio dei vasi comunicanti) e sono sospinte ancora più in alto, fino all'altopiano di Cigliano, per opera di due turbine azionate da una portata di 7 metri cubi al secondo del Canale Depretis, transitante in prossimità, ma ad un livello leggermente più alto. Le acque del Depretis vengono poi scaricate nel Canale del Rotto, a livello ancora più basso del Depretis. In tal modo l'innalzamento di 20 metri di parte delle acque del Naviglio di Ivrea avviene sfruttando l'energia idraulica del Canale Depretis e dunque senza utilizzo di energia elettrica.
I lavori furono terminati nel 1882. Il costo di realizzazione, di circa 160.000 lire dell'epoca (oltre 500 mila euro attuali) fu sostenuto per intero dai membri del consorzio irriguo. L'amministrazione delle Regie Finanze concesse gratuitamente, con obbligo di restituzione, la portata d'acqua del Canale Depretis, necessaria per la sollevazione delle acque del Naviglio d'Ivrea. Per la derivazione delle acque dal Naviglio d'Ivrea si applicarono invece i prezzi in vigore.
L'Elevatore idraulico è un'opera di notevole valenza tecnica, per il periodo in cui fu realizzato, e di fondamentale importanza ancora oggi per l'irrigazione di un comprensorio agricolo di 1100 ettari (4000 giornate piemontesi), nei comuni di Cigliano, Moncrivello, Villareggia e Borgo D'Ale, che si trovano a quote altimetriche più alte di qualunque fiume o canale della zona e dunque non potrebbero essere diversamente irrigati.
L'Elevatore Idraulico è di proprietà del Consorzio Irriguo di Cigliano-Borgo D'ale-Moncrivello-Villareggia. E' visitabile su appuntamento chiamando il numero del Consorzio (Cigliano, 0161423134).
Cigliano: monumento titolato a don Evasio Ferraris collocato nella piazza che porta anche il suo nome.
Piazza Don Evasio Ferraris
Monumento a Don Evasio Ferraris
Il ruolo politico del Cavour
Una svolta decisiva all'irrigazione della nostra zona fu data dal Cavour. Il
ruolo fondamentale svolto dallo statista fu soprattutto politico. I canali derivati
dalla Dora appartenevano al demanio, che li affittava per contratto ad appaltatori.
Costoro, in gran parte speculatori, subaffittavano i cavi a proprietari e coltivatori
della zona lucrando profitti e creando una situazione di conflitti permanenti.
Cavour propose di riunire tutti gli utenti in un'unica associazione che fosse
concessionaria delle acque demaniali e ne amministrasse la distribuzione per
conto proprio. Nel 1853 scadevano i vecchi contratti di concessione agli appaltatori
e il Cavour, che era riuscito nel frattempo a costituire le associazioni degli
utenti potè illustrare e chiedere l'approvazione della legge con cui
si concedevano le acque della Dora Baltea. Si erano venute a creare così
le premesse legislativo-politiche entro cui si potè sviluppare il progetto
del Canale Cavour.
Nel 1869 veniva aperto il Canale
Cavour, il cui lontano progetto era già stato concepito da padre
Tommaso Bertone da Cavaglià nel 1633. Derivato
a Chivasso dal Po confluisce nel Ticino dopo un percorso
di 82 km. capace di 200 mc/sec di portata con uno sviluppo di 450 km. di
canali per i tronchi principali e 754 km. per quelli secondari. E' in grado
di rendere irrigua una superficie di 20.000 ha. Il canale Cavour modificò
totalmente le condizioni agricole piemontesi, tant'è che la produttività
della terra raddoppiò e in certi casi triplicò. Il possibile sfruttamento
intensivo del terreno fece nascere una nuova popolazione operaia rurale, con
le stesse caratteristiche sociali dei lavoratori dell'industria.
La fine della I guerra mondiale
La fine della I guerra mondiale non portò al paese quei cambiamenti che,
in particolare, gli agricoltori si aspettavano. Era stato loro promesso, quale
indennizzo di guerra, terra da coltivare. Trovarono invece al ritorno dal fronte,
contratti da fame, imposti dai latifondisti che in gran parte trascorsero la
guerra in salotto.
Gli agricoltori si ribellarono, al loro fianco si schierarono i socialisti.
Ben presto, comunque, al verificarsi di scioperi continui, i proprietari favorirono
l'insorgere del fascismo. Fu ristabilita la pace sociale. Il regime, inizialmente
promosse un'intensa e capillare azione di bonifica su tutto il territorio nazionale.
La sconfitta della bonifica integrale
Il 12 settembre 1929 viene nominato segretario per l'agricoltura con competenza
per i problemi della bonifica integrale Arrigo Serpieri. Nel 1934 il Serpieri
viene esonerato dalla carica. La sua linea, di rigorosa applicazione della legislazione
sulla bonifica, viene sconfitta, poiché comportava l'esproprio per i
proprietari inadempienti. In un discorso del 12 dicembre 1934 denuncia gli interessi
privati dei proprietari che tendevano a sottrarsi agli obblighi e ai costi derivanti
da un'applicazione piena della legge. Nella posizione del Serpieri si esprimeva
certamente un momento di elevato senso politico, ma sicuramente, era troppo,
per un governo che badava solo agli interessi di alcuni ceti , sui quali si
basava poi lo stesso governo.
Il Consorzio irriguo di Chivasso provvede alla distribuzione idrica nel proprio
territorio, scarsamente irrigato in precedenza dalle ultime propaggini del Canale
di Caluso. Tale consorzio, nato nel 1921, acquisì nel 1926, dal consorzio
irriguo di Caluso la concessione reale del 1923 di derivare dalla Dora Baltea
2270 l/m/s per irrigare il comprensorio dei comuni di Rondissone, Torrazza,
Verolengo, Chivasso, e Montanaro. Benchè nel 1921 si fosse iniziato a
Mazzè l'impianto di elevazione (detto di Villareggia), il Consorzio di
Chivasso non potè attendere e provvide alla costruzione di un nuovo impianto
con quattro gruppi elevatori, ciascuno dei quali in grado di sollevare 800 l/m/s
d'acqua per un'altezza di 34 m. L'opera che comprende 17 km. di canale, terminò
il 15 maggio 1928, dopo solo sette anni di lavoro, e già in quell'anno
provvide all'irrigazione di 2000 ha mentre l'anno successivo ne comprendeva
già 3000.
Dal libro " LA DIGA DI MAZZE" (inedito) di Francesco
Mondino
Gli organismi che si preposero alla realizzazione della diga di Mazzè
Nel 1910 si costituisce il Consorzio irriguo di Villareggia, per unire i proprietari
terrieri dello stesso paese e di Moncrivello,Cigliano, Maglione, Borgo d'Ale,
Alice Castello, e Cavaglià. Primo presidente sarà l'avvocato Angiono
Foglietti. Il programma, che indicava di derivare 24 moduli d'acqua (1 modulo
equivale a 100 litri al secondo) dal fiume Dora Baltea "per l'irrigazione
con mezzi meccanici" di una superficie di 3120 ha circa, entrava finalmente
nella sua prima fase operativa. In seguito nasceranno i consorzi di Mazzè
e di Chivasso per la parte non irrigua situata sulla sponda destra della Dora
Baltea. Un decisivo apporto all'opera fu dato dalla "Società Anonima"
costituitasi in seno alle officine meccaniche e metallurgiche di Caluso.
Progetto e costruzione della diga di Mazzè
Dai consorzi irrigui e dalla Società Baltea, costituitasi legalmente
nel 1920, furono promosse tutte le iniziative che dovevano portare all'esecuzione
del progetto della diga di Mazzè, elaborato dai fratelli Tartaglia Giuseppe
e Giovanni, dall'ingegner Italo Bertoglio e, per le strutture in cemento armato,
dall'ingegner Alberto Pozzo. I
lavori di costruzione ebbero inizio nel 1921 e l'esecuzione dell'opera continuò
per tutto il 1922. Le opere di carattere stabile furono essenzialmente due :
la traversa mobile vera e propria, portante nella parte superiore la struttura
di cemento armato che serve da sostegno e di manovra delle paratoie e delle
tubazioni; poi l'edificio della centrale destinato al controllo delle turbine,
delle pompe degli alternatori e dei collettori dell'acqua sollevata. A queste
opere maggiori si aggiunsero quelle più generali per
la formazione del bacino (tra cui lo sfioratore a monte della centrale).
Allo spirare dell'anno 1922, la diga di Mazzè , poteva dirsi realizzata.
La messa in carica del bacino avveniva il 1/12/1922.
Nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1924 una improvvisa quanto inopinata piena
della Dora Baltea scosse tremendamente la struttura della diga. Le acque del
fiume, precipitarono con irruenza, contro i manufatti che subirono un urto formidabile.
La diga fu scavalcata dalle acque che premevano da tutte le parti, i muri di
contenimento iniziarono a dare segni di cedimento, lasciando fuoriuscire da
grosse crepe flutti d'acqua schiumosa. Gli uomini di servizio , assediati da
quella improvvisa inondazione, fecero quanto loro in grado per alleggerire la
diga dalla forte pressione, ma i loro sforzi furono frantumati dalla fatica
e dagli elementi che turbinavano tutt'intorno. Qualche scossa più forte
fece gemere, nel bacino di carico, lo sfiatatore, un resistente muro in cemento
armato sorretto da grandi pilastri. Poi , uno squarcio terribile, un boato assordante
e di quel muro non restò che qualche moncone emergente dall'acqua limacciosa.
In quel disastro persero la vita l'ingegner Alberto De La Forest De Ivonne,
direttore dello stabilimento, e Vittorio Casali, capo tecnico.
Il progetto di ristrutturazione e consolidamento della diga
di Mazzè
La nuova opera fu concepita dall'ingegner Euclide Silvestri, titolare della
cattedra di idraulica alla R. Scuola di ingegneria "Politecnico di Torino",
che apportò sostanziali modifiche all'impianto e lo completò con
la costruzione di un nuovo scaricatore sul lato destro della centrale, in corrispondenza
del varco che l'acqua aveva aperto . Il lavoro si protrasse fino al 1928. Le
varianti apportate dal nuovo progetto furono rilevanti, e consistettero, nella
elevazione dei pilastri e delle spalle di m. 2,50, nella sostituzionedi 40 paratoie
verticali , parzialmente preesistenti con altre 10 paratoie verticali, parzialmente
automatiche, nel rafforzamento della platea stessa con sovrastrutture in cemento
armato, nella costruzione di un nuovo edificio scaricatore, oltre ad altre modifiche
e perfezionamenti che interessarono le apparecchiature elettroniche "in
genere".
L'intervento della Cassa di Risparmio di Torino ruolo e significato
Quando al termine dei lavori di consolidamento della diga fu riattivata la gestione
dell'impianto, sugli organi responsabili si abbattè una grave crisi finanziaria.
Il consorzio non era più in grado di assolvere ai propri impegni. Il
fiato si fece grosso, i problemi, ormai fuori dalla portata della amministrazione
consorziale agitavano i sonni degli uomini , il rischio imprenditoriale era
andato oltre il previsto. Questa crisi aveva già avuto qualche grosso
effetto negativo fin dal 1927 con lo scioglimento dell'amministrazione consorziale
e la nomina di un commissario straordinario . Erano in pericolo la continuità
di esercizio dell'impianto e la posizione degli agricoltori consortisti, sulle
cui proprietà incombeva la minaccia del pignoramento. Fu la Cassa di
Risparmio di Torino, il maggior istituto creditore nei confronti del disciolto
consorzio, a prendere le redini in mano e a trarre d'impaccio gli agricoltori.
Trasformatasi da finanziatrice a diretta concessionaria, seppe riorganizzare
la complessa gestione lasciata dai vari organismi affermando con autorità
e competenza un vasto programma di bonifica economica ed agraria.
Le caratteristiche attuali dell'impianto
La complessa struttura è costituita da diverse parti così sintetizzabili:
L'edificio principale di presa, lungo m.77,50 che presenta 5 campate divise
in altri setti intermedi di 10 luci
L'edificio scaricatore, costruito dopo l'infortunio del 1924, con criteri uguali
a quelli della traversa mobile.
E' diviso 5
campate, senza alcun setto
intermedio.
Gli elementi di ritenuta sono costituiti da paratoie di uguale larghezza, con
sfioratori automatici come nell'edificio principale.
L'edificio della centrale propriamente detta, che ha una superficie di 990 mq
e una cubatura di 17.820mc.
Esso comprende le camere di carico delle turbine, il salone principale delle
macchine, la sala dei comandi idrodinamici per le paratoie quella degli accumulatori
elettrici, le officine di riparazione i magazzini , gli uffici.
Le caratteristiche costruttive delle turbine permettono di sfruttare una caduta
massima di m.6,60 e una portata massima di25000 l/s alle turbine sono accoppiate
altrettante pompe per il sollevamento dell'acqua per l'irrigazione, identiche
sono calcolate per una portata di 1200 l/s ad una prevalenza di 60 m. Completano
il complesso macchinario innumerevoli apparecchiature ed impianti.
L'immagine dell'impianto di irrigazione di Mazzè in
Italia e in Europa
Come esperimento di elettro-irrigazione con sollevamento d'acqua a grandi altezze,
l'impianto di Mazzè fu considerato uno dei più importanti d' Europa.
Nelle sue caratteristiche costruttive e meccaniche si rilevò il risultato
di un'alta tecnologia e rappresentò una conquista di ingegneria idraulica
di grande valore. Considerato fra i maggiori e più caratteristici d'Europa
, divenne palestra di insegnamento attirando molti studiosi e dirigenti di importanti
settori economici. Fu un punto di riferimento di grande significato e, di volta
in volta, visitato, oltre che da professori e studenti di politecnici, anche
da molti stranieri. Accolse così, delegazioni di vari paesi europei ,
asiatici e dell'America meridionale, Francia, Jugoslavia, India, Cina, Uruguay,
e poi molte personalità politiche e non . Un'opera dunque, che aveva
espresso compiutamente il suo significato.
Dalla ricostruzione post-bellica ad oggi
Il consorzio di bonifica operò come ricostruttore delle opere distrutte
o danneggiate dalla guerra, poi come ausiliario dell'intervento di riforma agraria,
nella predisposizione delle infrastrutture necessarie alle nuove aziende agricole,
poi ancora come agente di sviluppo nel grandioso programma per le irrigazioni
intraprese nel mezzogiorno, a seguito della costituzione della cassa per il
mezzogiorno, ed in altre regioni, a seguito dei finanziamenti pluriennali istituiti
a partire dal 1961, con i piani verdi. Con l'istituzione delle regioni i consorzi
assunsero nuove prospettive. Consorzi, regioni, bonifiche, politiche del territorio,
restano comunque istituzioni che assumono ora, connotati diversi, al cospetto
della politica agricola della sempre più allargata comunità europea.


Foto eseguite nel 2011 con descrizione dell'impianto


IMPIANTO DI POMPAGIO DORA
Intertventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea
-Primo Stralcio funzionale-
Costruzione della stazione di sollevamento Dora
LAVORI IN CORSO
LIDIA MASSIA
17 FEBBRAIO 2021
Mazzè:
Centrale idroelettrica
I LAVORI SONO QUASI ULTIMATI
INAUGURAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ALLA CENTRALE DI MAZZÈ (TO) 20 dicembre 2022
Filmato
home page
CLICCANDO IN BASSO A SINISTRA
RISULTA VISIBILE
IL NUMERO DEI VISITATORI DELLA PAGINA
"UN FIUME UNA DIGA CENTO CANALI "
A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2023
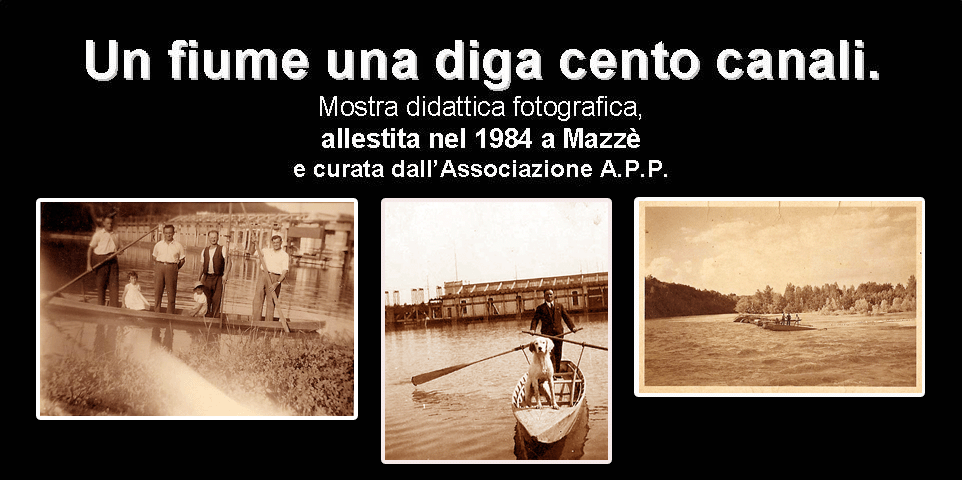
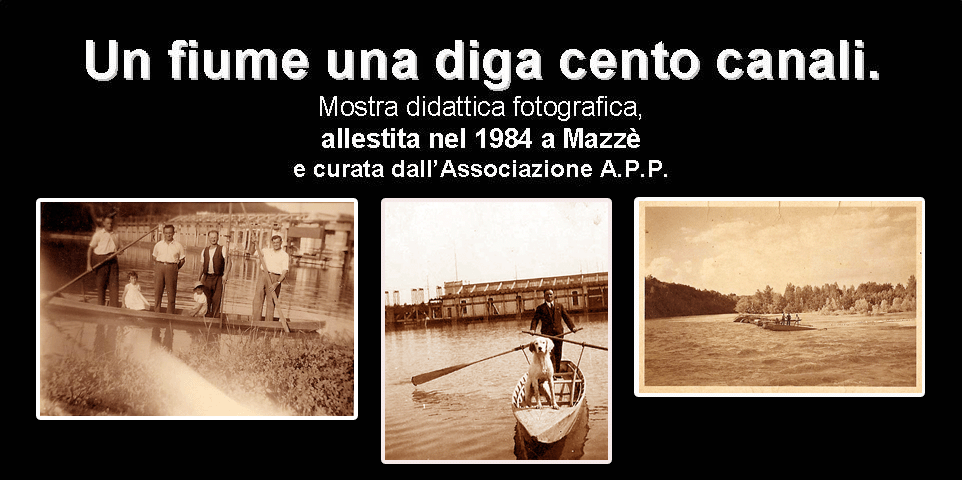
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()