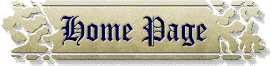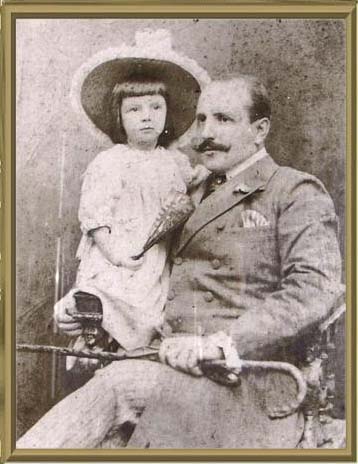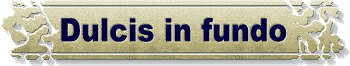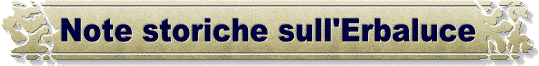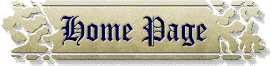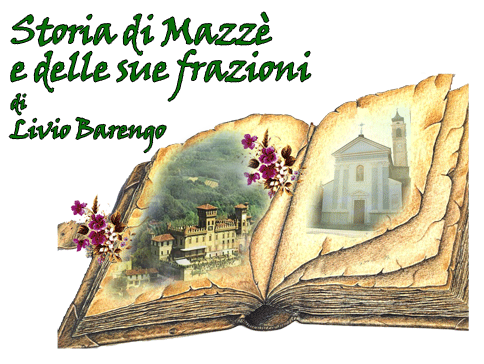
PERIODI
AVVENIMENTI STORICI
CHE
HANNO CONTRIBUITO
AL NASCERE E ALL'EVOLVERSI
DELLA COMUNITA' MAZZEDIESE



LA DISCESA IN ITALIA DEI FRANCHI DI CARLO MAGNO
LA RESISTENZA DEI LONGOBARDI DI RE DESIDERIO
IL VALLO LONGOBARDO DI VIVERONE
IL VALLO LONGOBARDO DI VIVERONE
IL CAMPO TRINCERATO LONGOBARDO DI MAZZE'
CONSIDERAZIONI SUL CAMPO TRINCERATO LONGOBARDO DI MAZZE'

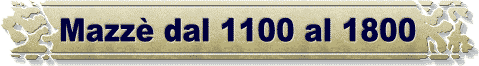
NOTE
SUL
"DE
BELLO CANEPICIANO"
DI
PIETRO AZARIO
Notaio, nato a Novara nel 1312.
Tra i suoi numerosi scritti
il
"De bello canepiciano",
ovvero le Guerre del
Canavese,
un'opera originale ed
importante per il nostro territorio,
perché narra le
vicende riguardanti le guerre feudali
svoltesi nel periodo
mediano del secolo XIV°.
(Grazie
al Comune di San Martino Canavese)

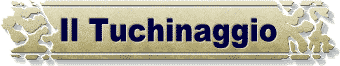

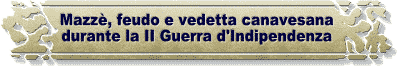
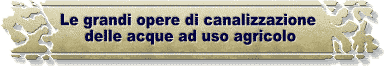






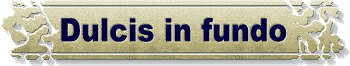

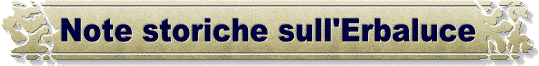
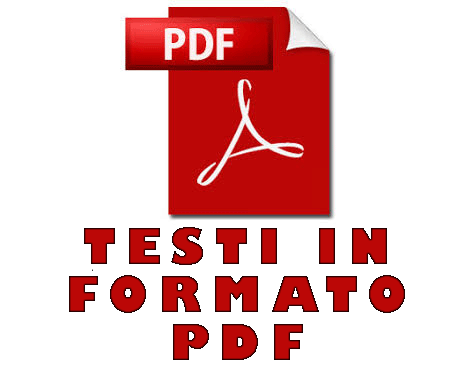

L’origine di
Mazze’
e’ antichissima
probabilmente
da far risalire
ai primi stanziamenti che i
Liguri
crearono sulle loro
strade
di transumanza
nel
X sec. A.C.
poste solitamente vicino ai fiumi.
La pianura
che sorge tra
a quel tempo era probabilmente occupata
da una sorta di palude
che gli autoctoni
Liguri
ed i successivi invasori
Celti
bonificarono
allo scopo di ricavare terreni atti all’agricoltura.
Reperti
notevoli di questo periodo sono la
datata dalla Sovrintendenza Archeologica del Piemonte al
VI sec.
A.C.
e l’ara incisa visibile nel luogo in cui la stele e’ stata
esposta al pubblico
(Mazze’ nel giardino di Piazza della Repubblica.)
L’etimologia
del nome di Mazze’
secondo gli ultimi ritrovamenti,
deriverebbe dal nome
della dea celtica
meglio
da noi conosciuta come Morgana,
in quanto si presuppone che a Mazze’ esistesse
un centro di culto a lei dedicato.
Di questo periodo e’ di notevole interesse
che ricorda i lavori di bonifica della palude culminati in una tragedia che coinvolse tutto il popolo di Mazze’.
Si narra, difatti, che la leggendaria
avesse ordinato di
per una disillusione d’amore, facendo cosi’ sommergere tutto l’abitato.
Nel III sec. A.C.
l’espansionismo
romano incomincia ad interessare
il
Canavese
e naturalmente anche
Mazze’.
Nel
il console romano
Appio Claudio Pulcro
con il suo esercito invade, con motivi pretestuosi,
popolazione creatasi dalla
fusione tra gli
autoctoni Liguri ed i Celti.
I romani vengono sconfitti lo stesso
anno presso
Verolengo
ma successivamente riprendono l’offensiva
ed a loro
volta
sconfiggono i Salassi di pianura
tra
Mazze’ e Vische.
Nel 100 A.C.
il console romano
Caio Mario
dopo aver debellato i Teutoni,
fonda,
con l’aiuto
dei Salassi canavesani,
Ivrea,
a difesa della
strada delle
Gallie.
Nel 22 A.C.
il console Varrone
sconfigge definitivamente i Salassi della Valle d’Aosta
vendendo i superstiti come schiavi.
Tutto il Canavese,
compresa quindi Mazze’,
viene centuriato
ed i poderi assegnati ai veterani.
La fusione di questi con
i
Salassi
dara’ origine
ai nostri progenitori.
Probabilmente a quel tempo
nel territorio di Mazze’
esistevano
due insediamenti romani:
come testimoniato dalla lapide
funeraria di epoca imperiale
ritrovata nella chiesetta di San Lorenzo ed
attualmente locata nella chiesa parrocchiale.
Per quanto concerne, invece, la
regione San Pietro
dell’insediamento fanno fede i reperti
recentemente sistemati a cura del Comune di Mazze’ e della Associazione
culturale "F. Mondino"
in una bacheca sita presso la sala consiliare.
Con le invasioni barbariche tutto il tessuto sociale viene
sconvolto.
La gente, per cercare riparo,
abbandona i siti romani per trasferirsi
sul cucuzzolo della collina piu’ alta,
facilmente difendibile.
Purtroppo
in questa migrazione gli edifici e le strade esistenti vengono smantellati per
costruire nuove abitazioni.
Notevole, in questo periodo, e’ il transito
per Mazze’
della strada militare romana
conducente dal presidio di
pattugliata da mercenari Sarmati
agli ordini
di un prefetto Romano.
Si ritiene interessante ricordare che i Sarmati erano
barbari originari della Russia,
sconfitti e fatti prigionieri dall’imperatore
Costantino nel 337 D.C.,
dopo che avevano attraversato il Danubio e invaso l’impero.
Con l’avvento dei
Longobardi
prima,
dei
Franchi
poi,
la societa’ canavesana assume una struttura
di tipo germanico
ed il potere
viene preso, di fatto, da famiglie nobili franche.
Un membro della famiglia
Valperga
nel 1110
diventa
conte
di
Mazzè.
Le vicende di questa famiglia
seguiranno quelle del popolo di Mazzè per i successivi otto secoli.
Nel
medioevo
i signori di Mazzè
ed il suo popolo sono
prima guelfi
e poi
ghibellini,
ma, in ogni caso,
sempre contrari ai
Savoia.
Figura preminente di
questo periodo è
Signore di Mazzè,
generale e consigliere
dell’Imperatore
Sigismondo,
al tempo delle guerre in
Boemia
contro gli

Nei secoli seguenti
Mazzè
partecipa
alle vicende del
ducato di Savoia
prima,
Regno di Sardegna
poi,
venendo invasa
nel XVI secolo
dai Francesi
e in seguito
dagli Spagnoli.
Nel XVIII secolo,
sia
per venire incontro all’aumento della popolazione e sia sull’onda
delle ventate riformiste francesi,
la comunità di Mazzè decide
di captare,
a sue spese,
una
dal
canale di Caluso
allo scopo di irrigare i territori della pianura.
Questo fatto provocherà un parziale abbandono del ricetto
esistente attorno al Castello
per stabilirsi sul piano
e lo sviluppo di
Tonengo,
favorendo l’immigrazione
di vari nuclei familiari,
probabilmente dall’astigiano.
La costruzione
della
darà luogo a varie
controversie
con il
Conte Valperga
contemporaneo,
vicende che sfoceranno, già al tempo della rivoluzione francese,
nella costruzione di un
in frazione Casale,
in spregio ai diritti feudali del Conte.
Nel XIX sec.
sciaguratamente
il ricetto fortificato
viene quasi interamente distrutto
per far posto ai Palazzi
nobiliari
attualmente ancora visibili.
Allo scadere della prima meta’ del secolo
muore
senza lasciare eredi.
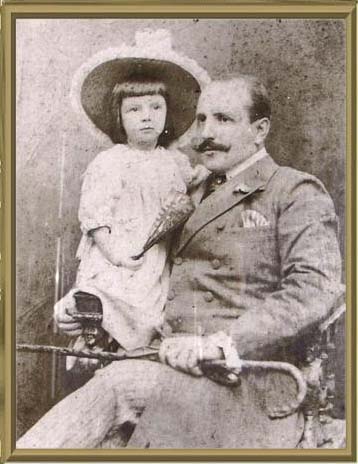
Il castello,
ridotto quasi ad un rudere,
viene, dopo varie
vicissitudini, acquistato dalla famiglia dei
conti Brunetta d’Usseaux,
nobili francesi da sempre al servizio dei Savoia.
Fortunatamente il figlio di
uno degli acquirenti,
il conte
sposa una nobildonna russa parente dello zar Nicola II,
rimanendo pero’ purtroppo vedovo in giovane eta’ e padre di quattro
figli.
Con le ingentissime sostanze ereditate dalla moglie
il conte procede
al riattamento del castello
trasformandolo in un edificio neo – gotico,
come si presenta tutt’oggi.
Nel XX sec., dopo la tragica morte del conte
Eugenio,
avvenuta nel 1919,
per il castello inizia un periodo di decadenza
e del Principe di Piemonte
per risollevarne le sorti.
Attualmente il maniero e’ di proprieta’ di una facoltosa famiglia russa.
Va riconosciuto alla famiglia Salino, che nella proprietà precedette i russi,
il merito di aver proceduto ad ingenti opere di restauro.
Dopo un lento decremento demografico,
negli ultimi decenni la popolazione di Mazze’ e’ andata crescendo,
grazie anche ad una discreta immigrazione,
raggiungendo quasi la soglia dei
4000 abitanti,
impiegati per lo piu’ nell’industria e nel terziario.
Il primo sindaco del Comune, di nomina reale, e’ stato il Cav. Carlo
Birago;
Mazze’, e’ stata la patria di vari personaggi
illustri,
tra i quali va ricordato particolarmente, oltre a
gia’ citato in precedenza,
singolare figura di sportivo e mecenate.
Rimarchevole e’ stato il contributo che egli diede,
quale amico di
per la riedizione dei giochi olimpici,
diventando, inoltre, segretario generale
del C.I.O.
(Comitato Internazionale Olimpico)
dal 1896 al 1919,
data della sua
morte.
Merito particolare del conte fu l’assegnazione, all’Italia,
delle olimpiadi del 1904,
non svoltesi poi a Roma per l’opposizione del
Vaticano.
La figura del conte Eugenio
Brunetta d’Usseaux e’ stata recentemente oggetto di una
edita dal C.O.N.I.
nell’abito delle iniziative per supportare la candidatura
di Roma per le olimpiadi del 2004,
poi assegnate ad Atene.

Qual è l'origine del nome "
Mazzè"?
Mazzè, deriva dal celtico Mattiacu. Giandomenico Serra, illustre glottologo
canavesano, conferma la sua antica origine, derivando molto probabilmente da
Mattiaca, la Morrigan irlandese, la dea celta della guerra e dell'oltretomba,
signora dei guadi. Non per nulla a Mazzè esistono gli unici guadi praticabili
sulla Dora Baltea e, certamente la tenebrosa dea non concedeva il suo nome a
caso.
Chi furono gli antichi abitanti di Mazzè?
Mazzè ha tracce più o meno evidenti dei popoli che qui si sono
succeduti
dall’età del ferro sino ai giorni nostri, basta cercare e vedrete
scorrere
davanti ai vostri occhi le vicende di un paese che ha sempre avuto il controllo
dei guadi sulla Dora, ricavandone prosperità ed influenza.
Ogni popolazione, ogni epoca, ha lasciato qui la propria impronta:
Salassi con la ricerca dell'oro.
Romani con le strade, i ponti, le fortificazioni e la vite.
Per ottocento anni, dai primi anni dell'XI sec. sino al 1840, il feudo dei
Conti Valperga-Mazzè, con il Castello ed il ricetto.
Mazzè vanta di aver ospitato, quale suo cittadino per vari decenni, il
conte
Eugenio Brunetta D'Usseaux, primo e sino ad ora unico italiano, segretario del
Comitato Olimpico Internazionale.
Ma chi era mai questa regina Ypa?
La configurazione del Canavese, cosi come oggi noi lo conosciamo, è dovuta
al
deflusso delle acque del mitico gran
lago canavesano attraverso la forra di
Mazzè.
La decisione di Ypa, leggendaria regina
dei Salassi, di tagliare la collina
morenica più lunga d'Europa non fu certamente dettata solo dal desiderio
di
bonificare terre vergini, ma dalla consapevolezza che il nuovo corso della Dora
Baltea avrebbe creato un confine, una sorta di termine tra la sua gente e quella
della pianura vercellese, favorendo la nascita di una cultura autonoma.
La leggenda narra ancora, che la regina Ypa,
una strega misteriosa e perversa
si servì delle sue arti e dei suoi poteri per commettere nefasti e infami
crimini.
Si racconta infatti che si fosse innamorata di un suo schiavo , e che, per
disfarsene, abbia perpetrato un progetto diabolico
Ordinò ai suoi servi, governati dall'innamorato, di tagliare la rocca
di Mazzè
e di scavare il nuovo letto della Dora.
Quando i lavori furono pressochè ultimati , fece rompere improvvisamente
gli
argini e le dighe, che a monte continuavano a mantenere le acque nel loro antico
letto, deviando il fiume verso Mazzè.
Gli schiavi tra i quali c'era l'amante furono colti inaspettatamente dal
traboccare delle acque che scendevano con i mpeto violento e, travolti e
sommersi dalla corrente, vi trovarono la morte.
Pare tuttavia, che la regina Ypa poco abbia goduto del suo sogno, perché
Giove, accortosi della scomparsa del lago, volle punirla, e la condannò ad
errare perennemente entro i confini del suo regno, divenuto per lei un luogo
tenebroso, costringendola a fare ammenda della sua rivolta con una lunga
espiazione.
Al tempo in cui i romani si spinsero in questa regione, pare che vi fossero
delle terre non completamente asciutte.
Lo starebbero a dimostrare le strade da essi costruite, poste tutte ad una
certa altura, incastrate sui fianchi elevati dei monti e delle colline.
E i romani, quando arrivarono?
I Romani giunsero nelle nostre terre nel 143 a C.. Tutto venne sconvolto.
Nell’intento di aprirsi una strada verso le Gallie, il console Appio Claudio
Pulcro conquistò, dopo vari tentativi, tutto il Canavese.
EPOREDIA-QUADRATA
Estremo baluardo contro l'invasione dei barbari
La strada Eporedia-Quadrata
e le strutture ad essa collegate, della cui
esistenza si è ormai autorizzati a credere a seguito della scoperta,
sono la
prova incontrovertibile degli sforzi che da Costantino in poi gli Imperatori
romani misero in atto nel tentativo di fortificare il limes italico contro le
invasioni barbariche nella penisola.
EPOREDIA-QUADRATA
Il ruolo del Canavese con Milano capitale dell'Impero d'occidente
Perché, in un periodo di decadenza morale e materiale quale fu il basso
Impero
romano, si sono profuse energie e mezzi per costruire opere di questa portata
in
una zona marginale?
Quale necessità c’era di porre mano a progetti di simile entità e quale
riorganizzazione subì il Canavese, dopo Costantino, a conseguenza
dell’elevazione di Mediolanum a capitale dell’Impero d’Occidente?
Non sono certamente domande accademiche in quanto la loro soluzione potrebbe
fornire una risposta ai problemi che assillano da sempre i Comuni posti sul
tracciato della vecchia via militare che si dettagliano in: Verolengo, Torrazza
Piemonte, Rondissone, Mazzè, Vische, Candia, Strambino ed Ivrea. E’ possibile
che ulteriori scoperte possano far comprendere nel novero anche Caluso,
Chivasso, Strambino e Villareggia, in quanto territori certamente interessati
da
tronchi stradali laterali, confluenti poi nell’arteria principale nord-sud.
Perché nel IVsec.D.C. i romani costruiscono la strada militare Quadrata-Eporedia
transitante per Mazzè?
Al tempo dell'Imperatore Flavio Valentiniano le frontiere imperiali erano
talmente esposte agli attacchi dei barbari che anche la scorta di Costanza,
figlia di Costante II suo predecessore e fidanzata di suo figlio, fu attaccata
dalla popolazione germanica dei Quadi.
La principessa si salvò solo con una fuga precipitosa.
Con questo stato di cose l'imperatore fece fortificare le frontiere, tracciare
strade lungo i fiumi in modo che le sue legioni potessero manovrare rapidamente
e creare campi trincerati per l'acquartieramento delle truppe in tutti i luoghi
possibili.
Cosi narra Ammiano Marcellino, storico romano del IV sec. d. C.
Questa è molto probabilmente la motivazione della costruzione nel IV
sec. D.C.
della strada militare Quadrata (Verolengo) - Eporedia (Ivrea) transitante per
Mazzè.
Temendosi un'invasione dalla Valle d'Aosta, occorreva sveltire i collegamenti
tra le guarnigioni di cavalieri Sarmati stanziati ad Eporedia ed a Quadrata,
per
rendere questi ultimi in grado di intervenire rapidamente.
Quadrata è distrutta.
Nasce Chivasso.
I conti di Mazzè costruiscono la "Via Mazenga"
Per l'economia di Mazzè, la distruzione di Quadrata prima, probabilmente
avvenuta nel VI sec d.C. e la fondazione di Chivasso poi, furono eventi
catastrofici.
Il traffico di merci ed il transito di pellegrini si spostarono sulla
direttrice Ivrea - Strambino- Caluso- Chivasso, centri sino allora non uniti
da
alcuna strada, dimenticando l'antica via romana Ivrea- Strambino-Carrone- Mazzè-
Quadrata.
Conti di Mazzè, per ovviare alla rovina del loro feudo, provvidero alla
costruzione della Via Mazenga, collegante il nuovo centro di Chivasso con Mazzè
ed il suo ponte sulla Dora, per il quale transitava ancora certamente il
traffico verso Milano.
Nel XIV sec. con la distruzione del ponte, avvenuta durante le guerre del
Canavese, ogni motivo di transito attraverso l'antico centro romano-salasso
venne meno ed il traffico si indirizzò definitivamente verso altre direzioni.
L’esistenza della Strada Mazenga ebbe però un altro effetto in
quanto, lungo
essa nel XVIII secolo si stanziarono dei coloni monferrini i quali, con
l’aumento della popolazione, unirono le loro cascine formando Tonengo.
I nuovi venuti intendevano mettere a coltura, dopo la costruzione del Canale
di Caluso e le sue diramazioni, le terre sino allora tenute prevalentemente
a
pascolo tra Mazzè e Chivasso, alienate dal Demanio reale nel 1796 per
sopperire
alle spese di costruzione della Mandria.
Lungo quale percorso si snodava la Via Francigena?
Comunemente si crede che la Via Francigena fosse una specie di percorso fisso
immutabile, quasi una superstrada della devozione.
In realtà la Via Francigena era un reticolo di strade dirette ai luoghi
di
transito obbligato.
Per i pellegrini provenienti dalla Francia e transitanti per la Valle d'Aosta
il punto nodale era ovviamente Ivrea. Lasciata questa città i percorsi
tendenti
a sud erano almeno due e ricalcavano quel che restava delle strade selciate
antiche.
Il primo, come già ampiamente illustrato in altre pubblicazioni, era
quello
che transitava per Ivrea-Santhià-Vercelli seguendo l'antica Via delle
Gallie.
Il secondo, per noi più interessante, era quello che ricalcava l'antica
strada
militare romana Ivrea - Quadrata
con Mazze' ed il suo ponte sulla Dora nel punto
mediano.
In proposito vale la pena di ricordare quanto afferma il Serra nei suoi
scritti "Alle mete religiose dei pellegrini va riferita la propagazione
lungo le
vie romee del culto particolare d’alcuni santi quali S. Pietro, l'apostolo
venerato nella basilica pontificia in Roma, S. Giacomo di Compostela e S.
Michele, celebrato dai suoi due maggiori santuari, l'uno sul Monte Gargano,
l'altro in Normandia, cui s’intitolarono nel Canavese molte chiesuole
antiche,
oltre che a Carrone, a Mazze' (Monte S. Michele anno 1792), ad Ugliacco ecc."
Così proseguendo a proposito della donazione del ponte di Mazze' fatta
nel
1156 da Guido, Conte del Canavese, ad una congregazione religiosa "la larga
base
economica concessa alla loro congregacio per lo sviluppo dei suoi fini sociali
riesce a dimostrare come il Ponte di Mazzè non fosse solo un luogo importante
di
transito mercantile, ma dei pellegrini cui doveva essenzialmente mirare, oltre
alla difesa ed alla conservazione del ponte, l'attività di quei consortes
pontieri, investiti di carattere religioso, quale par scaturire dall'atto di
donazione del conte Guido ".
La via dei pellegrini quale qui riproposta non coincide esattamente con
l'antica strada militare romana in quanto molto probabilmente nell'alto medioevo
le condizioni ambientali del territorio vicino alla Dora ne rendevano il
percorso molto disagiato, ma era un tracciato posto più in alto sulle
colline,
in modo da evitare i miasmi della palude.
Dopo Ivrea i luoghi di sosta erano fissati presso la chiesa di Santo Stefano
a
Castiglione di Candia, gestita dai monaci dei Santi Nicolao e Bernardo di Monte
Giove.
A Mazzè provvedeva all'assistenza la congregazione religiosa, creata
dal Conte
del Canavese per gestire il ponte.
Dall'altra parte della Dora ad Ugliacco sulla Via de Mazato diretta a Vercelli
esisteva una casa ospitaliera, sempre dei monaci del Gran San Bernardo, unita
alla chiesa di Santa Maria d’Oliade.
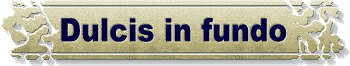

Si narra che Papa Giulio II,
il pontefice protettore di Michelangelo vissuto nella prima metà del
XVI secolo, inviasse periodicamente in Canavese suoi emissari con l’incarico
di acquistare, per le mense vaticane, il vino passito prodotto nelle campagne
di Mazzè e di Caluso.
Non si sa se questa diceria è vera, corrisponde però certamente
a verità la tradizione che per secoli, nel basso Canavese , si è
prodotto il vino passito dall’uva erbaluce a fini quasi esclusivamente
medicinali. A quel tempo era opinione comune che se un malato, curato con sostanziose
bevute di passito, non migliorava, era chiaro che il poveretto era certamente
afflitto da una malattia grave alla quale solo Dio poteva provvedere.
Nelle famiglie contadine, sino alla prima metà del secolo scorso, la
preparazione del passito era un avvenimento con una sua liturgia particolare,
rigorosamente rispettata. Al momento della vendemmia il capo famiglia sceglieva
e metteva da parte i grappoli di erbaluce più belli. Le donne di casa,
dopo aver scartato gli acini non degni dell’onore, disponevano i grappoli
su dei tavolati di legno, sui quali era stato posato in precedenza uno strato
di paglia, posti nei solai. Nel mese di marzo dell’anno successivo, dopo
aver scartato quelli ammuffiti, i grappoli erano pigiati e torchiati sino a
ricavarne un mosto denso, dolcissimo, emanante un profumo inconfondibile che
lentamente permeava tutti gli ambienti.
Dopo qualche tempo si provvedeva ad
effettuare il primo travaso per eliminare il deposito formatosi sul fondo della
damigiana, a questo ne sarebbero seguiti moltissimi altri durante i sei anni
canonici di invecchiamento. Alla fine si otteneva un vino liquoroso mediamente
alcolico, denso, di colore tendente quasi al marrone. Al palato il sapore era
dolce, ma con un retrogusto inconfondibile che ne caratterizzava sia la qualità sia la provenienza.
Normalmente la produzione famigliare
di passito non era commercializzata, serviva alla famiglia durante l’anno,
nelle malattie e nei momenti di gioia o per onorare un ospite particolarmente
gradito.
Oggigiorno non credo esistano ancora
famiglie che producano il passito col metodo tradizionale, in genere l’uva
erbaluce è fatta appassire artificialmente ed il ricavato non è
più travasato, ma filtrato con mezzi meccanici.
Ad ogni buon conto, anche se non più
lavorato come tradizione comanda, il vino passito attuale mantiene in buona
parte il gusto e le proprietà organolettiche di quello antico. Un bicchierino
di passito bevuto nei momenti di maggior stress sicuramente sortirà effetti
migliori di molti anti depressivi di gran moda.
In ultimo il lettore ricordi che non
esiste vino passito a poco prezzo, se ve lo propongono diffidate, quasi certamente è stato contraffatto con il taglio di vini liquorosi meridionali.
Barengo Livio
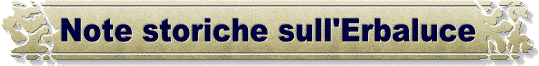
" Il vitigno Erbaluce coltivato
sui suoli morenici allo sbocco della Valle d'Aosta, pur mostrando aspetti ormai
particolari dovuti all'evoluzione locale della cultura ed alle peculiarità
microclimatiche, è in sostanza strettamente imparentato al Greco delle
colline novaresi e della bassa Valsesia (Fara, Sizzano, Ghemme, Romagnano, Gattinara
ecc...).
In effetti, poiché la denominazione
Erbaluce appare in attestazioni relativamente recenti, sembra di poter riallacciare
tale produzione a quella tipica della colline moreniche piemontesi del Greco,
attestata anche in documenti basso medievali.
La definizione di Greco, frequente
nelle attestazioni dei banchetti medievali in tutta Italia, ha una sopravvivenza
tra gli attuali D.O.C. nel solo Greco di Tufo (prodotto oggi soprattutto nell'Avellinese;
famoso quello dell'Az. Agricola Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico), di
cui è stata ormai dimostrata su basi scientifiche la corrispondenza con
il vitigno dell'Aminea Gemella degli antichi autori latini.
Lo stesso Virgilio dichiara (Georgiche
II, 97-98) Sunt et Amineae vites, firmissima vina, Tmolius adsurgit quibus et
rex ipse l'hanaeus
(Vi sono anche le viti Aminee, vini
resistentissimi, di fronte ai quali stanno in rispetto il Tmolio (famoso vino
da un monte di Lidia) ed il Re Fanco (vino per eccellenza della punta meridionale
dell'isola di Chio).
In età romana l’Aminea,
coltivata su bassi pergolati a sostegno morto e caratterizzata da un vino con
leggeri riflessi verde-chiaro, originaria probabilmente della Campania (in particolare
dall'area flegrea e della Valle del Sabato) è diffusa verso nord da coltivatori
etrusco-italici nelle colonie romane a cominciare dal Lazio (in particolare
Velletri) e dal borgo d’Aminea nel Piceno, cui probabilmente deve la denominazione.
Presente nel Mantovano (per questo
cara a Virgilio) potrebbe essere stata portata in Piemonte dalla colonizzazione
romana, a partire dagli italici assegnatari di lotti nella centuriazione eporediese
(100 a.C.) e messa a cultura con pergolati a sostegno morto (a differenza degli
alteni, in alberata, di tradizione preromana locale) approfittando anche di
mano d'opera servile esperta proveniente dalla Gallia narbonese (entroterra
di Marsiglia), cui si deve la penetrazione nel tardo latino del Piemonte e successivamente
nel dialetto del termine - carasso -, derivato da un termine tecnico greco che
significa " sostegno per vite ".
In ogni caso è probabile che,
proprio per sopperire alla debolezza dei bianchi locali per lo più legati
a vitigni d’origine selvatica (come il Solanus delle Alpi Marittime, rinforzato
con resina vegetale), sia stata l'età romana ad introdurre in Piemonte
gli antenati del Greco e dell'Erbaluce, se non nei primi momenti della colonizzazione
comunque al più tardi in piena età imperiale.
La distribuzione geografica dell'Erbaluce
potrebbe dunque dipendere anche proprio dal collegamento alla colonia eporediese,
restituendoci in una tradizione antica un'altra testimonianza della storia del
nostro territorio.
L'ultimo epigono della famiglia dei "carass" di Mazzè, caratteristico personaggio detto "Mini
ad carass", è morto in tarda età una decina d’anni
fa.
Certamente non supponeva che l'appellativo
col quale era chiamata la sua famiglia avesse origini così illustri,
crediamo che se fosse stato edotto ne sarebbe rimasto certamente sconcertato.